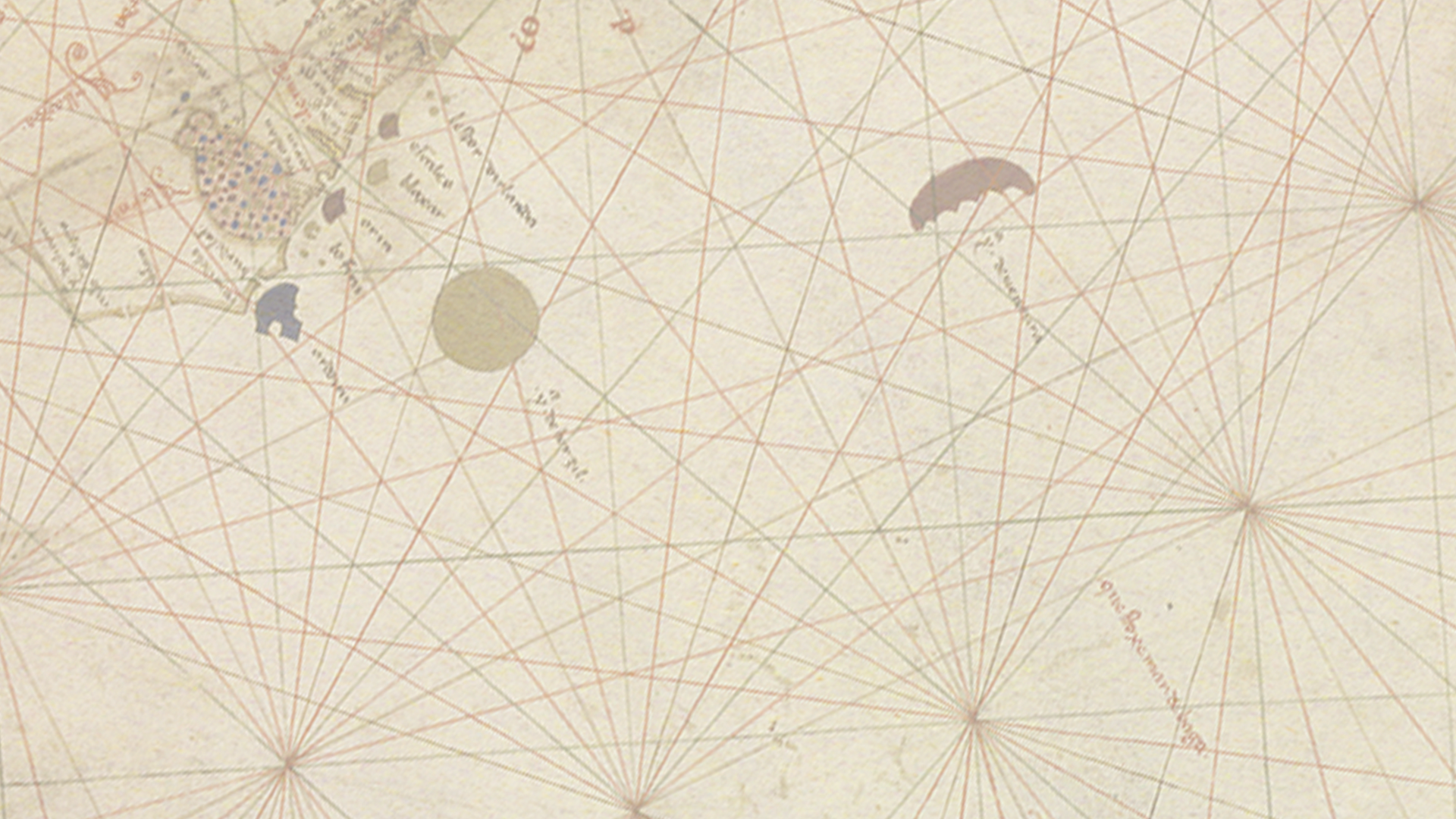
Pubblicato il:
Iscriviti alla newsletter
Al Teatro dell’Opera di Roma, una “Butterfly” che non invecchia
Testo del comunicato
“Madama Butterfly” viene sottotitolata “tragedia giapponese in tre atti” di Luigi Illica e Giuseppe Giocosa basata sull’elegante racconto di John Luther Long, letto però attraverso gli occhiali del drammone nazional-popolare di David Belasco che Puccini vide probabilmente al “Lirico” di Milano (non a Londra, come dicono le leggende). Essere considerata una “tragedia”, per di più “giapponese” ed essere eseguita “in tre atti”, è una iattura che perseguita l’opera di Giacomo Puccini da quando, dopo il tonfo alla prima rappresentazione alla Scala nel febbraio 1904, cominciò, riveduta e corretta, il cammino trionfale nell’edizione presentata a Brescia (molto vicina all’assestamento definitivo nel 1906). In effetti, nella concezione modernissima di Puccini (molto più innovativa di quanto compreso da Belasco, Illica e Giacosa, nonché da tanti interpreti pure dei giorni nostri), sotto l’aspetto drammaturgico e musicale “Butterfly” è divisa in due parti molto distinte: la prima da commedia borghese (molto poco “giapponese”, cugina anzi delle commedie borghesi di inizio Novecento), la seconda da dramma in cui dimensioni intimistiche acquistano valenza universale (tramite una progressiva scoperta della verità, in delicato equilibrio, quindi, tra Pirandello e Sofocle). Dal contrasto (soprattutto musicale) tra la prima e la seconda parte nasce la bellezza e la modernità di un’opera spesso invecchiata, negli allestimenti, dall’orientaleggiare “art nouveau” di maniera e dall’intervallo salottiero dopo il coro a bocche chiuse (magnifico nesso tra i due quadri della seconda parte). Il Teatro dell’Opera di Roma, dove è in scena fino al 28 maggio, fa quindi benissimo a presentare il lavoro in due parti, come è d’altronde prassi nei maggiori teatri stranieri.
Sotto molti punti di vista, “Butterfly” è sorella di “Jenufa” di Léos Janaceck; tre settimane prima, nel gennaio 1904, quest’ultima vedeva la luce in un teatrino allestito per l’occasione nella sala da tè della piccola città di Brno e avrebbe dovuto attendere dodici anni prima di essere conosciuta come uno capolavori assoluti del Novecento. Il merito principale dell’esecuzione del Teatro dell’Opera di Roma è l’aver colto tutta la modernità di “Butterfly”. Spetta in primo luogo a Daniel Oren che, sebbene noto principalmente come bacchetta per opere popolari, ha un orecchio fino per la musica contemporaneo: da eccellente concertatore, scava sia nelle notazioni orchestrali da commedia borghese della prima parte sia in quelle di dramma, al tempo stesso intimista e universale, della seconda; l’abile scrittura di Puccini, spezzettata (altro accostamento con “Jenufa”) e densa di citazioni orientali ed americane ma al tempo stesso fluida in un flusso orchestrale ininterrotto, viene esaltata a tutto tondo, mantenendo sempre un grande equilibrio con le voci. Pochi sanno infatti che in “Butterfly” ci sono circa 50 leit motive intrecciati in una maniera che ricorda più Debussy che Wagner.
Altra scelta vincente dell’esecuzione è l’avere ripreso il bell’allestimento scenico del compianto Aldo Rossi e l’attenta regia di Stefano Vizioli (vista per la prima volta a Bologna a fine anni Ottanta); nell’impianto fisso e nell’astuto gioco di luci e di lanterna magica, la commedia della prima parte e il dramma della seconda si giustappongono perfettamente. Sino all’anticipo finale del “Wozzeck” di Alban Berge, altro capolavoro del Novecento in cui l’intimismo assurge a valenza universale: il bambino di Butterfly gioca sul cavalluccio di legno al piano alto mentre a quello basso la madre fa hara-hiri, proprio come il figlio di Wozzeck e Marie nell’ultimo quadro dell’opera di Berg. È un segno che pur in Italia come a Vienna ed a Berlino gli allestimenti, se ben pensati, invecchiano bene con gli anni come un Pommard Clos de la Féguine. Infine, le voci, importantissime in un’opera come “Butterfly” che a pieno titolo appartiene all’età d’oro del teatro in musica.
A Roma il lavoro è stata presentato con tre cast che si alternavano nei ruoli principali. Amarilli Nizza, criticata in precedenza (forse troppo severamente) per avere accettato il doppio ruolo di Margherita ed Elena in “Mefistofele”, è una Butterfly perfetta tanto scenicamente quanto localmente: il pubblico l’ha applaudita con vere e proprie ovazioni negli acuti. Insomma, una Butterfly di grande classe: non è la fragile eroina dell’iconografia di maniera ma una regina, un vero e proprio gigante rispetto al piccolo mondo dei suoi familiari, del “ricco Yamadori”, del mezzano Goro, del buon burocrate Sharpless e del meschino Pinkerton. Quasi alla sua altezza (senza però raggiungerla) sono solo lo “zio Bonzo” e il ricordo del padre suicida per ordine del Mikado. Il Pinkerton di Marco Berti schiacciato da tanta grandezza eccede negli acuti e storpia qualche nota. Ben calibrato lo Sharpless di Franco Vassalloi. Una Suzuki affettuosa e intelligente è Francesca Franci, un Goro intrigante Mauro Bolognesi. Buoni tutti i numerosi caratteristi. Infine il coro, guidato da Andrea Giorni, che ha completato a bocche chiuse un’esecuzione memorabile, che prova come la fondazione romana non vada lasciata indietro nella normativa sulla lirica in fase di messa a punto.
fonte dati: IL VELINO
Sotto molti punti di vista, “Butterfly” è sorella di “Jenufa” di Léos Janaceck; tre settimane prima, nel gennaio 1904, quest’ultima vedeva la luce in un teatrino allestito per l’occasione nella sala da tè della piccola città di Brno e avrebbe dovuto attendere dodici anni prima di essere conosciuta come uno capolavori assoluti del Novecento. Il merito principale dell’esecuzione del Teatro dell’Opera di Roma è l’aver colto tutta la modernità di “Butterfly”. Spetta in primo luogo a Daniel Oren che, sebbene noto principalmente come bacchetta per opere popolari, ha un orecchio fino per la musica contemporaneo: da eccellente concertatore, scava sia nelle notazioni orchestrali da commedia borghese della prima parte sia in quelle di dramma, al tempo stesso intimista e universale, della seconda; l’abile scrittura di Puccini, spezzettata (altro accostamento con “Jenufa”) e densa di citazioni orientali ed americane ma al tempo stesso fluida in un flusso orchestrale ininterrotto, viene esaltata a tutto tondo, mantenendo sempre un grande equilibrio con le voci. Pochi sanno infatti che in “Butterfly” ci sono circa 50 leit motive intrecciati in una maniera che ricorda più Debussy che Wagner.
Altra scelta vincente dell’esecuzione è l’avere ripreso il bell’allestimento scenico del compianto Aldo Rossi e l’attenta regia di Stefano Vizioli (vista per la prima volta a Bologna a fine anni Ottanta); nell’impianto fisso e nell’astuto gioco di luci e di lanterna magica, la commedia della prima parte e il dramma della seconda si giustappongono perfettamente. Sino all’anticipo finale del “Wozzeck” di Alban Berge, altro capolavoro del Novecento in cui l’intimismo assurge a valenza universale: il bambino di Butterfly gioca sul cavalluccio di legno al piano alto mentre a quello basso la madre fa hara-hiri, proprio come il figlio di Wozzeck e Marie nell’ultimo quadro dell’opera di Berg. È un segno che pur in Italia come a Vienna ed a Berlino gli allestimenti, se ben pensati, invecchiano bene con gli anni come un Pommard Clos de la Féguine. Infine, le voci, importantissime in un’opera come “Butterfly” che a pieno titolo appartiene all’età d’oro del teatro in musica.
A Roma il lavoro è stata presentato con tre cast che si alternavano nei ruoli principali. Amarilli Nizza, criticata in precedenza (forse troppo severamente) per avere accettato il doppio ruolo di Margherita ed Elena in “Mefistofele”, è una Butterfly perfetta tanto scenicamente quanto localmente: il pubblico l’ha applaudita con vere e proprie ovazioni negli acuti. Insomma, una Butterfly di grande classe: non è la fragile eroina dell’iconografia di maniera ma una regina, un vero e proprio gigante rispetto al piccolo mondo dei suoi familiari, del “ricco Yamadori”, del mezzano Goro, del buon burocrate Sharpless e del meschino Pinkerton. Quasi alla sua altezza (senza però raggiungerla) sono solo lo “zio Bonzo” e il ricordo del padre suicida per ordine del Mikado. Il Pinkerton di Marco Berti schiacciato da tanta grandezza eccede negli acuti e storpia qualche nota. Ben calibrato lo Sharpless di Franco Vassalloi. Una Suzuki affettuosa e intelligente è Francesca Franci, un Goro intrigante Mauro Bolognesi. Buoni tutti i numerosi caratteristi. Infine il coro, guidato da Andrea Giorni, che ha completato a bocche chiuse un’esecuzione memorabile, che prova come la fondazione romana non vada lasciata indietro nella normativa sulla lirica in fase di messa a punto.
fonte dati: IL VELINO
© 2021 MiC - Pubblicato il 2020-10-27 22:27:13 / Ultimo aggiornamento 2020-10-27 22:27:13
